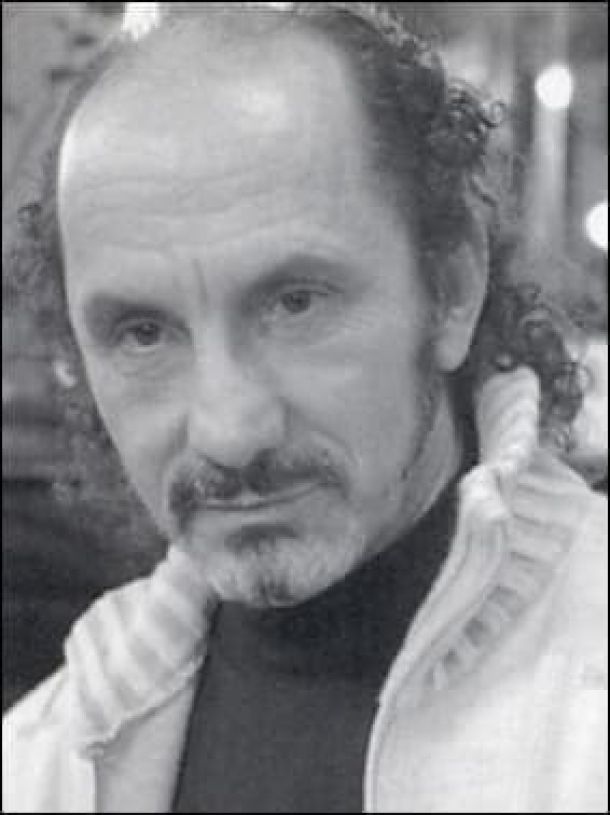Il tempo di cambiare, di Paul Ginsborg
Pagina 1 di 3
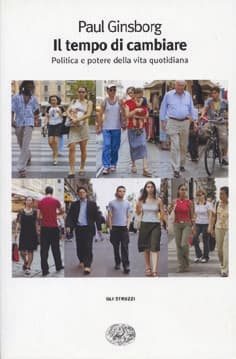 Coloro che oggi hanno venti o trent’anni avvertono, a pelle, una netta sensazione: c’è qualcosa che li differenzia, parecchio, dalla generazione dei loro genitori; e non è qualcosa di cui felicitarsi.
Coloro che oggi hanno venti o trent’anni avvertono, a pelle, una netta sensazione: c’è qualcosa che li differenzia, parecchio, dalla generazione dei loro genitori; e non è qualcosa di cui felicitarsi.
I venti-trentenni di oggi sono cresciuti con una consapevolezza malinconica; con la percezione di un retrogusto acidulo, poco rassicurante, sempre presente nella fruizione del loro benessere e nella loro visione del futuro. La ricostruzione posteriore alla Seconda guerra mondiale, per un ventennio almeno, era avvenuta all’insegna di un palpabile ottimismo di fondo. Con l’entusiasmo di un’avventura proiettata al meglio; verso un avvenire che si sapeva, necessariamente, più illuminato della caverna d’odio e distruzione in cui l’umanità giaceva riversa dopo il conflitto. Certo, anche quell’ottimismo non si è mai presentato liscio e cristallino, vissuto del tutto in pace e serenità; bensì era percorso da una sorta di isteria, dovuta al terrore dell’atomica, all’incubo che il pianeta potesse saltare in aria, da un momento all’altro. Vuoi per un precipitare improvviso delle relazioni tra i due blocchi: Usa e Urss. Vuoi, semplicemente, per un bottone premuto in un lampo di follia da qualche oscuro Dottor Stranamore: si trovasse in una base ai piedi degli Urali o nelle vallate del Kentucky. Eppure, negli effervescenti anni Cinquanta, ma soprattutto negli stralunati Sessanta, era come se non si pensasse più di tanto al domani. O meglio: ci si pensava, sì, sempre però in un’ottica di riforma perfettibile. Non si aveva paura del futuro. Lo si affrontava a viso aperto, sicuri di sé, consci di poterlo piegare ai propri desideri.
Molti di coloro che sono stati giovani allora lo possono confermare. Le preoccupazioni, un certo tipo di preoccupazioni, sono venute dopo, con i figli grandi, nella piena maturità. Crucci, questi, che hanno a che fare coi figli; che riflettono esattamente quelli dei figli, oggi venti o trentenni. Si può dire che la spinta dell’ottimismo, propria del dopoguerra, si è drammaticamente esaurita e ci ha lasciato a secco tutti quanti. È successo questo: che si è modificato in maniera decisa il rapporto che intrattenevamo col futuro. Oggi, possiamo appartenere alla generazione dei genitori, o a quella dei figli, ma nessuno di noi guarda più al futuro con un atteggiamento sicuro di sé. La prospettiva che abbiamo davanti non ci sembra ispirare un senso di illimitato miglioramento. È come se sapessimo che il conto alla rovescia è partito. Chi, oggi, è sotto i quaranta ha più di un sospetto che non sarà in grado di garantire alla propria discendenza un livello di vita pari, o migliore, rispetto a quello ereditato dai propri genitori.