Il tempo di cambiare, di Paul Ginsborg
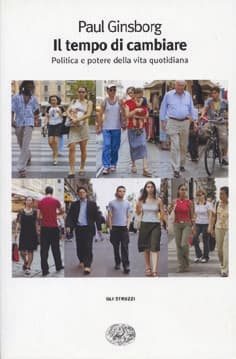 Coloro che oggi hanno venti o trent’anni avvertono, a pelle, una netta sensazione: c’è qualcosa che li differenzia, parecchio, dalla generazione dei loro genitori; e non è qualcosa di cui felicitarsi.
Coloro che oggi hanno venti o trent’anni avvertono, a pelle, una netta sensazione: c’è qualcosa che li differenzia, parecchio, dalla generazione dei loro genitori; e non è qualcosa di cui felicitarsi.
I venti-trentenni di oggi sono cresciuti con una consapevolezza malinconica; con la percezione di un retrogusto acidulo, poco rassicurante, sempre presente nella fruizione del loro benessere e nella loro visione del futuro. La ricostruzione posteriore alla Seconda guerra mondiale, per un ventennio almeno, era avvenuta all’insegna di un palpabile ottimismo di fondo. Con l’entusiasmo di un’avventura proiettata al meglio; verso un avvenire che si sapeva, necessariamente, più illuminato della caverna d’odio e distruzione in cui l’umanità giaceva riversa dopo il conflitto. Certo, anche quell’ottimismo non si è mai presentato liscio e cristallino, vissuto del tutto in pace e serenità; bensì era percorso da una sorta di isteria, dovuta al terrore dell’atomica, all’incubo che il pianeta potesse saltare in aria, da un momento all’altro. Vuoi per un precipitare improvviso delle relazioni tra i due blocchi: Usa e Urss. Vuoi, semplicemente, per un bottone premuto in un lampo di follia da qualche oscuro Dottor Stranamore: si trovasse in una base ai piedi degli Urali o nelle vallate del Kentucky. Eppure, negli effervescenti anni Cinquanta, ma soprattutto negli stralunati Sessanta, era come se non si pensasse più di tanto al domani. O meglio: ci si pensava, sì, sempre però in un’ottica di riforma perfettibile. Non si aveva paura del futuro. Lo si affrontava a viso aperto, sicuri di sé, consci di poterlo piegare ai propri desideri.
Molti di coloro che sono stati giovani allora lo possono confermare. Le preoccupazioni, un certo tipo di preoccupazioni, sono venute dopo, con i figli grandi, nella piena maturità. Crucci, questi, che hanno a che fare coi figli; che riflettono esattamente quelli dei figli, oggi venti o trentenni. Si può dire che la spinta dell’ottimismo, propria del dopoguerra, si è drammaticamente esaurita e ci ha lasciato a secco tutti quanti. È successo questo: che si è modificato in maniera decisa il rapporto che intrattenevamo col futuro. Oggi, possiamo appartenere alla generazione dei genitori, o a quella dei figli, ma nessuno di noi guarda più al futuro con un atteggiamento sicuro di sé. La prospettiva che abbiamo davanti non ci sembra ispirare un senso di illimitato miglioramento. È come se sapessimo che il conto alla rovescia è partito. Chi, oggi, è sotto i quaranta ha più di un sospetto che non sarà in grado di garantire alla propria discendenza un livello di vita pari, o migliore, rispetto a quello ereditato dai propri genitori.
Che mondo abbiamo creato? Quale mondo lasceremo ai nostri bambini? Sono queste le domande, che hanno ripreso attualità negli ultimi decenni: con vigore sempre crescente. È almeno dagli anni Ottanta, infatti, che una serie di questioni, relative soprattutto al rapporto fra “Nord” e “Sud” del mondo (virgolettare è d’obbligo, in caso di simili generalizzazioni), e alla relazione fra produzione umana e ambiente, hanno acquistato contorni preoccupanti, tali da destare più attenzione di quanta vi è stata, nei fatti, dedicata. Solo molto di recente, tali questioni hanno guadagnato il posto che meritano nella coscienza diffusa. Come data simbolo è possibile, forse, indicare l’11 settembre 2001. La distruzione delle Torri gemelle a New York, tra le molte altre conseguenze, ha anche risvegliato, a livello di massa, una sensazione dimenticata da circa quarant’anni: «il timore per la nostra sopravvivenza, per i nostri cari, per la specie umana in generale», scrive Paul Ginsborg – grande storico dell’Italia contemporanea – nella Prefazione. Aggiungendo che una seconda, potente valenza simbolica di quel tragico avvenimento sta, anche, nell’aver dimostrato a quale intensità siano giunti certi «odii globali». Senza voler intendere, con ciò, che al-Qaeda abbia diritto ad avanzare qualche titolo di rappresentatività nei confronti del “Sud” del mondo, ovviamente. Ma solo per sottolineare come l’11 settembre abbia suonato, per il “Nord”, come un terribile campanello d’allarme, che deve indurlo a riflettere sul significato, e la praticabilità, degli odierni equilibri mondiali.
Ginsborg, fin dall’inizio, è chiarissimo. Titola il primo capitolo del suo saggio: “Non si può andare avanti così”. Ciò basti per capire quanto la sua posizione sia lontana dall’elogiare il «modello di modernità prevalente nei paesi sviluppati, un modello esportato e imposto al resto del mondo». Quanto, cioè, il suo sia un approccio fortemente critico verso alcuni aspetti, non tutti, di quell’insieme di processi economici e geopolitici, riassumibili nel concetto di “globalizzazione”. In particolare, occorre subito rilevare come l’essenza stessa della globalizzazione non sia condannata da Ginsborg: il che lo differenzia dal relativismo culturale, come dal velleitarismo politico, che caratterizzano altri atteggiamenti critici verso quel medesimo processo. Anzi, che aumentino le connessioni – culturali ed economiche – fra i diversi popoli della Terra, insieme alla loro consapevolezza di partecipare a un destino comune, è un fatto che l’autore sembra giudicare notevolmente positivo. Ciò che egli non condivide sono alcune ingiustizie precise, quanto palesi, alimentate dall’attuale modo di governare – o di non governare – la globalizzazione.
È indicativo il confronto che Ginsborg stesso pone, nella Prefazione, fra la sua tesi e quella di Francis Fukuyama, già celebre – e incauto – cantore della “fine della Storia”, tra anni Ottanta e Novanta, oggi sostenitore delle dottrine economiche neoliberiste più convinte e impazienti. Se Fukuyama, all’indomani dell’11 settembre, ebbe a commentare: «la modernità è un treno merci molto potente che non verrà deragliato dagli eventi recenti, per quanto dolorosi e senza precedenti»; Ginsborg, al contrario, è assai più incline a pensare che il modello di modernità, prevalente oggi in Occidente, sia un modello insostenibile. Che il nostro treno, a conti fatti, «deve essere riempito di altri beni» e che «i binari su cui viaggia devono mutare radicalmente direzione».
La sua analisi ha come punto di partenza un dato molto semplice: «alla fine del xx secolo i paesi ad alto reddito, che contavano il 15% della popolazione mondiale, controllavano l’80% delle risorse del globo, mentre i paesi a basso reddito, con il 50% della popolazione globale, possedevano solo il 5% delle risorse mondiali». È uno squilibrio evidente, potenzialmente molto pericoloso. Si tratta – afferma Ginsborg – di vedere se esistono le condizioni e i mezzi per correggerlo di nostra iniziativa. Altrimenti, presto o tardi, si correggerà da solo. È facile immaginare che le conseguenze, in quel caso, non saranno affatto positive: per noi “paesi ad alto reddito” in particolare, per la pace mondiale più in generale.
Il problema, per Ginsborg, è primariamente di ordine etico. Il sistema economico che sorregge il nostro benessere, il modello produttivo che sta alla base dello squilibrio, è ispirato essenzialmente a una logica di puro profitto, che non tiene conto, troppo spesso, dei più elementari principi morali. Anche senza scomodare la morale, è evidente come i ritmi del modello di produzione occidentale entrino in conflitto con le semplici regole dell’intelligenza. Perché – punto primo – le risorse disponibili, necessarie al mantenimento dell’attuale regime produttivo, iniziano a scarseggiare. Non ci si riferisce al petrolio, ma agli elementi basilari per il sostentamento di qualunque creatura vivente del pianeta: terra, foreste, aria e acqua pulite. E perché – punto secondo, correlato al primo – lo smaltimento dell’incredibile montagna di rifiuti, prodotta quotidianamente dai “paesi ad alto reddito”, non fa che degradare il bacino di risorse ancora usufruibili. È il pianeta stesso, perciò, che risente del nostro modello di vita, e che, a lungo andare, finirà per rigettarlo in blocco.
La dinamica del profitto a ogni costo, quindi, che governa le società consumistiche in cui oggi viviamo, pone in termini drammatici una questione, che attiene tanto alla morale (alla convivenza fra esseri umani), quanto all’intelligenza (all’adattabilità umana nell’ambiente). «Il consumo moderno – scrive Ginsborg – si basa su due premesse fondamentali: insaziabilità e crescita incrementale. Quasi ogni cosa che possediamo dev’essere sostituita e i nostri averi sono destinati a crescere in dimensioni e numero». Per concludere: «Scarto costante e accumulazione costante vanno quindi a braccetto. È la ricetta di un disastro».
Come evitarlo? «Che cosa può fare ciascun individuo – egli si chiede – per ribaltare il modello di consumo fortemente dannoso sopra delineato?». Specie se si considera quanto sia diffusa, fra la gente comune, la sensazione di impotenza. La quale si fonda, in genere, sul presupposto che qualunque cambiamento strutturale non possa partire dal basso; che manchino, nella vita quotidiana, gli strumenti e le possibilità effettive per incidere sul funzionamento complessivo della società, e sui meccanismi che la regolano. Il libro di Ginsborg si sforza di dimostrare il contrario. Se il libero mercato, sostiene l’autore, si fonda sulla libertà di scegliere cosa produrre e come produrre, è altrettanto vero che l’altra faccia della medaglia è costituita dalla libertà di scegliere cosa consumare, e come. La nostra vita quotidiana è composta da un succedersi continuo di consumi; ogni prodotto acquistato implica, a monte, una nostra scelta. E l’ammontare delle scelte individuali può dare luogo a un sorprendente effetto cumulativo. È necessario, quindi, riflettere sulla quota di potere nascosta in quelle che l’autore chiama le «microazioni», gli «interstizi» della vita quotidiana, al fine di innescare un processo dal basso di «trasformazione molecolare».
Per cominciare, dovremmo ragionare sulle motivazioni che stanno alla base dei nostri consumi, e sui loro effetti a catena. Senza inseguire violenti progetti rivoluzionari – come non smettono di proporre altri autori, altri “professori” sempre sulla cresta dell’onda, non saziati da tutto il sangue del secolo scorso – basterebbe fare, nel privato della nostra coscienza, un serio e sincero esame critico, e stabilire una separazione fra ciò che ci è necessario e ciò che ci è superfluo. Sarebbe già di grande aiuto utilizzare prodotti riciclati, e riciclare correttamente i nostri rifiuti. Chiederci – di regola – a quali condizioni di lavoro e in quali paesi vengono fabbricate le merci “occidentali” che acquistiamo, sotto l’influsso delle mode e della pubblicità. Privilegiare, sempre, le aziende che osservano codici di comportamento antisfruttamento. Informarci per sapere quali sono, e per scoprire se gli stessi prodotti si trovano anche sul mercato equo e solidale.
Non si può dire certo che la strada verso la «trasformazione molecolare» del sistema, suggerita da Ginsborg, ecceda in moralismo, in pedante spirito didattico. Il suo, è un invito – semplice – a sfumare il nostro individualismo edonista, e di far sì che ciascuno di noi si senta parte di una comunità, di una «società civile» attenta e responsabile, capace di orientare e stimolare con le sue scelte la «società politica», spesso in ritardo, o indifferente, o ancor peggio complice dei guasti – minimi e massimi, piccoli e grandi coincidono – della collettività. Non è il grande libro di un geniale teorico, ma è il manifesto di un buon cittadino, un appello caloroso – dettato dal buon senso, molto più che dalla sua cultura storica – a continuare a credere nella democrazia: a partecipare e a non delegare, dato che la vivacità della democrazia partecipativa, egli annota, garantisce la qualità di quella rappresentativa. Se, con le nostre in-azioni quotidiane, non coltiviamo la prima, favoriremo noi stessi il degrado della seconda. Insomma, è tempo di cambiare: è tempo di premiare il partito dell’intelligenza e della morale, e, quando questo manca, di agire in sua vece.
Paul Ginsborg, Il tempo di cambiare, Einaudi, Torino 2004.
Patrick Karlsen







