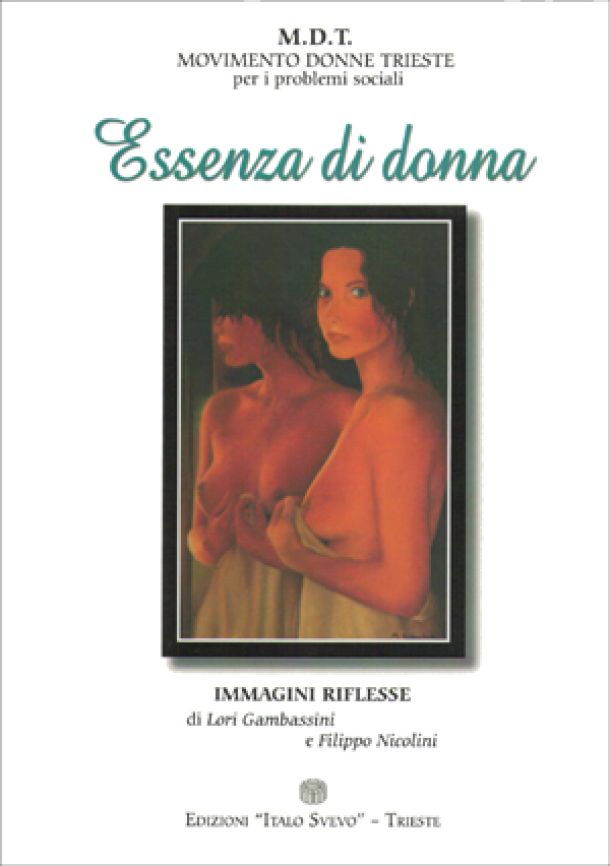Alla cieca, di Claudio Magris
Com’è naturale, più aumenta la distanza temporale e più il Novecento – per noi, posteri o superstiti che ne siamo – acquista maneggevolezza intellettuale. Più vengono incoraggiate le interpretazioni di insieme, i tentativi di inquadrarlo e di soppesarlo in un bilancio complessivo.
Ecco allora che lo si è detto il secolo della violenza, il secolo delle masse, il secolo dei totalitarismi, o all’opposto della democrazia; il secolo breve. Già disponiamo di un certo numero di definizioni, ora più, ora meno giustificate e penetranti. Tutti coloro però che si sono spinti nella riflessione più a fondo e con maggior frutto, sono concordi nel sottolineare, del Novecento, l’essenza supremamente ambiziosa: l’attitudine alla palingenesi e alla visione, la pretesa di partorire inauditi progetti di trasformazione della società e di plasmare le coscienze di uomini e donne che la compongono.  Colpisce soprattutto l’accanimento, con cui quel nostro secolo – non possiamo non dirlo nostro, padre o patrigno che esso sia – ha voluto condizionare l’immaginario dei singoli, la forma e il contenuto delle loro aspirazioni. Il potere totalitario, ha ragionato Vittorio Foa in Questo Novecento, si distingue da quello semplicemente autoritario perché non solo ti obbliga a obbedire, ma determina ciò che devi desiderare. Limitatamente a quest’ultimo aspetto, allora, sia quando lo si consideri nella stagione della terribile lotta a tre, fra nazifascismo, comunismo e democrazie, sia che lo si osservi nel suo volgere conclusivo, dominato su scala globale dal modello consumista di società, potremmo arrivare a concludere che il Novecento sia stato un secolo tutto totalitario. Che la sua originalità, cioè, il tratto di continuità strisciante sotto le sue diverse fasi ed esperienze, stia nella tendenza del potere – dei poteri al plurale – a invadere la sfera della coscienza individuale, a sfondare il diaframma fra pubblico e privato, a trapassare la soglia oltre cui palpita il nervo vivo dell’io.
Colpisce soprattutto l’accanimento, con cui quel nostro secolo – non possiamo non dirlo nostro, padre o patrigno che esso sia – ha voluto condizionare l’immaginario dei singoli, la forma e il contenuto delle loro aspirazioni. Il potere totalitario, ha ragionato Vittorio Foa in Questo Novecento, si distingue da quello semplicemente autoritario perché non solo ti obbliga a obbedire, ma determina ciò che devi desiderare. Limitatamente a quest’ultimo aspetto, allora, sia quando lo si consideri nella stagione della terribile lotta a tre, fra nazifascismo, comunismo e democrazie, sia che lo si osservi nel suo volgere conclusivo, dominato su scala globale dal modello consumista di società, potremmo arrivare a concludere che il Novecento sia stato un secolo tutto totalitario. Che la sua originalità, cioè, il tratto di continuità strisciante sotto le sue diverse fasi ed esperienze, stia nella tendenza del potere – dei poteri al plurale – a invadere la sfera della coscienza individuale, a sfondare il diaframma fra pubblico e privato, a trapassare la soglia oltre cui palpita il nervo vivo dell’io.
A simili congetture veniamo ricondotti proprio leggendo il nuovo romanzo di Claudio Magris – seguendo le avventure, in bilico tra il tragico e il picaresco, del suo protagonista: ufficialmente Salvatore Cippico (o Čipiko, o Cipico), paziente del Centro di salute mentale di Barcola (un paesino di mare alle porte di Trieste), che affida il resoconto della sua esistenza a un lungo e fluido monologo-fiume – referto clinico autorecitato davanti al medico che lo tiene in cura. Ufficialmente si è detto, e va ribadito: perché dal suo magmatico e caotico raccontare si dipanano costantemente le volute di altri percorsi biografici, tracce e frammenti dispersi di altre vite. Accade così che la voce narrante non sia (solo) quella di Cippico: l’antifascista deportato a Dachau, il comunista emigrato nel dopoguerra in Jugoslavia per contribuire alla costruzione del socialismo, e poi, a causa della sua fedeltà a Stalin, imprigionato nel gulag di Goli Otok – la spaventosa Isola Calva dove il regime di Tito era uso confinare i dissidenti. Ma che sia, la voce di Alla cieca, (anche) quella di Jorgen Jorgensen, l’avventuriero danese del XIX secolo, il quale fu, in mezzo a molto altro, viaggiatore, spia, fondatore di città e re d’Islanda per poche settimane. O che sia, ancora, quella di diverse sotto-identità discendenti dalle principali come in un processo di duplicazione cellulare, a conferire loro vita e nomi propri: Jan Jansen, Tore, Neveda, Strijèla… ognuna riflettente nell’amore di una corrispettiva figura di donna: Maria, Marja, Mariza, Mangawana, Norah. E che a reggere e collegare la babele di narrazioni, infine, vi sia il mito dell’eterno viaggio di Giasone, partito per la Colchide alla ricerca del vello d’oro, simbolo di una liberazione umana sempre smentita nell’orrore e nel sangue.
Questo romanzo dunque è in primo luogo la metamorfica e schizoide vicenda di un io diviso. In ciò lo si può individuare subito in linea con la ricerca dell’autore (e con lo spirito di Trieste: cicatrici le multiple grafie dei nomi, nella finzione del romanzo come nella realtà della città). Una ricerca tesa da molto tempo a indagare in campo letterario il tema dell’identità: in specie la frammentazione dell’io avvenuta in concomitanza del crollo – con Nietzsche, con Freud, con Planck, Einstein e Heisenberg, con la Grande Guerra – delle rassicuranti ma illusorie certezze del sapere tradizionale. Forse non è ozioso o troppo ardito notare, in generale, come gli esperimenti totalitari del Novecento, con la loro ossessiva volontà di schedare, catalogare, incasellare le identità individuali, irrompano proprio all’indomani del tracollo della modernità e della dispersione dell’io: quasi a incarnare in forme talora abnormi e aberranti, talora più sottili, il tentativo di ricomporne le schegge, di ricompattare e assegnare un posto a ciò che è atomizzato e smarrito. I rovesci, appunto, ma anche le fughe e i continui imboscamenti dei protagonisti di Alla cieca, richiamano precisamente l’immagine di questa caccia alla volpe dell’io; appaiono metafora della lotta, che i poteri costrittivi e invasivi di tutti i tempi – stati, partiti, tecnologie – ingaggiano contro la libertà dell’individuo.
Naturalmente, più un’identità è scissa e più è sfuggente, più è difficile per un potere acciuffarla e ingabbiarla. Scissa, o piuttosto disposta alle sfumature, pronta ad arricchirsi delle contaminazioni del viaggio – che è la vita. Pretendere di avere l’ultima parola sul mondo e su di sé significa inchiodarsi a terra, inibirsi la possibilità del mare aperto. «Ogni uomo è un marinaio anche se non sa di esserlo», dice Salvatore, perché solo nel mutamento e nella ricerca, nel rifiuto di pensarsi compiuti, solo rinunciando allo sbarco definitivo sulla terraferma, è possibile l’esperienza dell’autentica libertà. Prendere il largo e seguire il movimento delle onde, del resto, è stato il dettato dell’esistenza di Jorgen Jorgensen, le cui peripezie coronate di leggenda, dall’effimera sovranità sull’Islanda, alle scorrerie corsare sui mari ghiacciati, alla deportazione nella colonia penale in Tasmania, avvincono Magris e i suoi lettori non da ora (un suo articolo sull’argomento è del 1991).
Nel personaggio reale (o più o meno fantomatico) Jorgensen, così come nel fittizio Cippico, insomma, si trova figurata l’invincibile autonomia dell’individuo davanti alla brama di controllo di ogni autorità: il suo non cedere all’ipotesi della vita come Lager. E vi è scolpita, poi, l’indomita tempra di chi è libero anche nella sconfitta. O proprio nella sconfitta. Gli eroi del romanzo, infatti, non tradiscono, o tradiscono in quanto coartati, impossibilitati a non farlo: trascinati a forza nella corrente dei tradimenti epocali di cui si macchiano i grandi sistemi, le visioni del mondo cariche di speranze e di promesse. Sono queste immani visioni, prima di tutto, a tradire Jorgen-Salvatore; a saltare d’asse, facendo mutare d’un colpo paesaggi e prospettive. Il movimento senza pace della voce di Alla cieca, allora, appare un movimento persino illusorio, fissato com’è al perno di una intima coerenza, e subalterno a un moto generale di insanabile tribolazione. Insanabile e fatale: contraddizione, inganno e tradimento sono gli ingranaggi di tutta la Storia. Non solo quelli che hanno fatto scorrere l’ultimo secolo; e il romanzo, d’altronde, ne prende atto. Jorgensen che partecipa alla colonizzazione dell’Oceania e allo sterminio degli aborigeni, compiuto dagli europei nella presunzione di essere i portatori della civiltà superiore; Cippico che combatte e sconfigge il «drago» nazista, vagheggia per l’umanità un destino di concordia universale, vedendo nel comunismo lo strumento adatto a realizzarlo, e assiste infine all’impietosa rovina del sogno di rivoluzione; Giasone che risale dalla Colchide col vello, lasciando dietro di sé non edificazione e progresso, ma una scia implacabile di distruzione e di morte. Sono i capitoli di una stessa trama maledetta, le scansioni di un gioco atroce che si ripete sempre uguale nella Storia, quello dell’utopia che cede il posto al disincanto. E sono allegorie del nostro terrore: che la civiltà sia solo una parola, un giudizio di valore e non di fatto; che cioè la Storia sia un nonsenso. Dov’è l’ordine, dov’è il disordine, si chiede Salvatore-Jorgen: cos’è la civiltà, cos’è la barbarie?
Noi apparteniamo al tempo di Cippico, e il ricordo dell’ultima utopia infranta è ancora fresco. Parlare male del gigante steso a terra, si capisce, è facile e diffuso: è l’ottimo alibi di un frangente storico incapace di forgiare, su scala planetaria, credibili progetti alternativi di convivenza umana – per non dire di sogni e ideali meritevoli del nome. «Quando la rivoluzione è finita – osserva Magris – resta un gran parlare, perché non resta altro: tutti a blaterare, come gente che ha visto un pauroso incidente stradale e si ferma sul marciapiede, in crocicchio, commentando l’accaduto». Notevole che a restituire dignità, a illuminare l’universo di speranze e di valori di coloro che riponevano fede nel gigante ora caduto, sia un uomo che da scrittore ed editorialista non mancava di denunciare, nel silenzio pressoché generale, le colpe e i delitti che il gigante andava commettendo quando ancora era in piedi, temibile e temuto. Se Alla cieca, pertanto, è una gran prova di coraggio e di libertà intellettuale, oltre che una perforante meditazione sull’ambiguità della Storia, sugli abissi che si dischiudono dietro a ogni utopia – è altrettanto vero che è soprattutto un bel romanzo: colmo di suggestive pagine di avventura e di amore; e intessuto di una prosa preziosa, in grado di calarsi con scioltezza dalle vette della lingua letteraria, giù per i pendii del monologo arrembante, del discorso colloquiale, dello stream of consciousness. E disperato, sì, crudele come tutti i bei romanzi.
«La storia è un cannocchiale accostato all’occhio bendato. Ogni tanto, come dopo il combattimento con la Preneuse, guardo nella canna della pistola. Forse laggiù in fondo c’è qualcosa, la striscia che a Oriule, davanti a San Pietro in Nembi, divide il mare verde da quello blu, la sottile soglia della vita vera, ma I’m damned if I see it, in quel nero non c’è nulla né da una parte né dall’altra, potrei anche premere il grilletto, alla cieca, tanto non c’è nessuno».
Claudio Magris, Alla cieca, Garzanti, Milano 2005.
Patrick Karlsen